



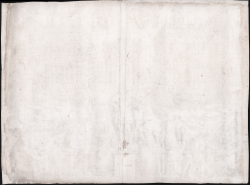
| Riferimento: | S50726 |
| Autore | Johann Frederick GREUTER |
| Anno: | 1610 ca. |
| Misure: | 375 x 285 mm |


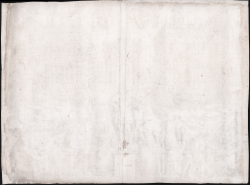
| Riferimento: | S50726 |
| Autore | Johann Frederick GREUTER |
| Anno: | 1610 ca. |
| Misure: | 375 x 285 mm |
La scena mostra un monarca - forse Rodolfo II, Imperatore del Sacro romano impero (Vienna 1552 - Praga 1612) - che si erge al centro circondato da figure allegoriche che rappresentano le virtù. L'opera è ricca di simbolismo, con figure che rappresentano giustizia, temperanza, fortezza e altre virtù cardinali che guidano il sovrano e la società. Sullo sfondo si ergono edifici che simboleggiano diverse virtù, come il "Templum Sapientiae" (Tempio della Sapienza) e la "Domus Temperantiae" (Dimora della Temperanza).
Stampa allegorica per illustrare la tesi di laurea di un ignoto studente, probabilmente per una discussione tenutasi al Collegio Germanico di Roma.
Bulino, circa 1610/12, firmato da Johannes Frederich Greuter in basso a sinistra.
Magnifica prova, stampata su carta vergata coeva, con sottili margini o rifilata al rame, minimi restauri nei lati, per il resto in buone condizioni.
In alto l’iscrizione AMDG, abbreviazione latina che sta per "Ad Maiorem Dei Gloriam", [A maggior gloria di Dio], motto della Compagnia di Gesù, meglio conosciuta come i Gesuiti.
Grazie all'opera di riformatori come Ignazio di Loyola, nel 1600 Roma era diventata una città di scuole. All'università di Roma, fondata all'inizio del XIV secolo, si aggiunsero il Collegio Romano, fondato dai gesuiti nel 1551, il Seminario Romano, le varie scuole nazionali (tra cui il Collegio Germanico, il Collegio Greco, e il Collegio Inglese), dedicate all'istruzione dei giovani cattolici provenienti da paesi non cattolici; il Collegio Clementino e molti altri collegi e accademie minori. Queste istituzioni rappresentavano nuovi importanti mercati per la produzione tipografica. I professori pubblicavano libri che necessitavano di frontespizi, mentre gli studenti celebravano le loro tappe accademiche pubblicando fogli volanti e opuscoli riccamente decorati con incisioni. L'impatto di tutto ciò sull'industria tipografica fu considerevole. All'inizio del XVII secolo, gli istituti scolastici di Roma erano tra i consumatori più importanti di stampe della città. L'anno accademico era scandito da discussioni di tesi, eventi di fondamentale importanza all'interno del sistema, che permettevano ai ragazzi più dotati e talentuosi di mostrare la loro eloquenza ed erudizione davanti a un pubblico d'élite. Le discussioni delle tesi generavano un grande quantità di materiale stampato, nonché il più elaborato. I “fogli volanti” (termine che si usa per descrivere delle singole pubblicazioni a stampa, non appartenenti a un libro o raccolta) che elencavano le “conclusioni”, o tesi, che lo studente avrebbe discusso divennero accessori essenziali, che, con il passare del tempo, vennero abbellite da incisioni ricche di virtuosismo artistico e iconografico, dando vita a una moda che sarebbe durata più di cento anni.
Le stampe progettate e realizzate appositamente per decorare i fogli volanti apparvero per la prima volta a metà del 1580 e nel 1590 era ormai prassi comune per gli studenti commissionare composizioni araldico-allegoriche grandi e imponenti per accompagnare le loro difese. Fin dall'inizio, queste stampe non erano solo decorative, ma avevano anche una funzione celebrativa. I gesuiti incoraggiavano i loro studenti a dedicare le loro tesi a personaggi importanti e influenti, sapendo che una dedica elegante e ben accolta aveva il potenziale di promuovere non solo le prospettive di carriera del difensore, ma anche la reputazione del collegio. La conclusione aveva, quindi, lo stesso scopo della dedicatoria: entrambi erano progettati per oliare i meccanismi del mecenatismo.
Tra i maggiori artisti/incisori che si specializzò in questo nuovo e particolare mercato grafico, ci sono Matthaeus e il figlio Johann Friedrich Greuter, i quali godevano chiaramente di un rapporto speciale con i gesuiti, a giudicare dal numero di stampe che realizzarono per loro e per i loro studenti. Matthaeus potrebbe aver stabilito un legame con la Compagnia anche prima di lasciare la Francia; e tra i gesuiti con sede a Roma c'erano tedeschi influenti che forse gli diedero una mano quando arrivò lì per la prima volta nel 1603. Questo spiegherebbe come sia riuscito a partire con il piede giusto, completando diverse grandi conclusioni per gli studenti del Collegio Romano e del Collegio Germanico prima della fine del 1604. Dopo aver preso piede nel mercato dei collegi, si affermò rapidamente come uno dei principali produttori di conclusioni a Roma. Cinquantotto stampe di tesi di Matthaeus sono elencate in The New Hollstein, ma sicuramente ne incise molte di più. Ne esistono almeno una dozzina non elencate e, dato che non sempre firmava le sue lastre, probabilmente ce ne sono molte altre ancora da identificare.
Queste tesi, sebbene probabilmente stampate in un numero cospicuo di esemplari, oggi risultano essere molto rare e solo pochi esemplari sono censiti nelle collezioni istituzionali di tutto il mondo. Non descritta in Hollstein e Rice.
Bibliografia
Louise Rice, Matthaeus Greuter and the Conclusion Industry in Seventeenth-Century Rome, in “Ein Priviilegiertes Medium und die Bildkulturen Europas, Deutsche, Franzosische und Niederlandische Kupferstecher und Graphikvetleger in Rom von 1590 bis 1630” Ròmische Studien der Bibliotheca Hertziana b.de 32, pp. 221-238; cfr. Jorg Diefembacher, The Greuter Family part III, J. F. Greuter, in “The New Hollstein”.
Johann Frederick GREUTER (Strasburgo 1590-93 circa - Roma 1662).
|
Incisore, figlio e scolaro di Matthäus Greuter, svolse in Roma la sua attività, dove lavorò per i Barberini, e fu molto apprezzato dai contemporanei. Johann Friedrich Greuter, che seguì le sue orme nella professione, si ritiene che sia nato intorno al 1590/1593. Tendiamo a classificarlo, come suo padre, come artista tedesco; ma dato che lasciò la sua terra natale durante l'infanzia e trascorse tutta la sua vita adulta a Roma, la sua germanicità era probabilmente piuttosto labile. Johann Friedrich era un incisore affermato a pieno titolo. Baglione riteneva che superasse il padre in abilità ed è vero che le sue opere sono in qualche modo più attraenti - o forse semplicemente più classicistiche, più “italiane” - di quelle del padre. Ma va anche detto che era meno versatile di Matthaeus. Il suo corpus consiste quasi interamente di composizioni figurative su temi religiosi, mitologici e allegorici. E mentre Matthaeus lavorava spesso sulle proprie invenzioni, Johann Friedrich non lo faceva quasi mai. Si limitava al ruolo di collaboratore, canalizzando attraverso il suo bulino le invenzioni altrui. Dopo la morte del padre, aprì una sua bottega vicino S. Ignazio. Riprodusse opere di Bernini, di Pietro da Cortona, di G. Lanfranco, ecc., e illustrò vari libri. Morì a Roma nel 1662.
|
Johann Frederick GREUTER (Strasburgo 1590-93 circa - Roma 1662).
|
Incisore, figlio e scolaro di Matthäus Greuter, svolse in Roma la sua attività, dove lavorò per i Barberini, e fu molto apprezzato dai contemporanei. Johann Friedrich Greuter, che seguì le sue orme nella professione, si ritiene che sia nato intorno al 1590/1593. Tendiamo a classificarlo, come suo padre, come artista tedesco; ma dato che lasciò la sua terra natale durante l'infanzia e trascorse tutta la sua vita adulta a Roma, la sua germanicità era probabilmente piuttosto labile. Johann Friedrich era un incisore affermato a pieno titolo. Baglione riteneva che superasse il padre in abilità ed è vero che le sue opere sono in qualche modo più attraenti - o forse semplicemente più classicistiche, più “italiane” - di quelle del padre. Ma va anche detto che era meno versatile di Matthaeus. Il suo corpus consiste quasi interamente di composizioni figurative su temi religiosi, mitologici e allegorici. E mentre Matthaeus lavorava spesso sulle proprie invenzioni, Johann Friedrich non lo faceva quasi mai. Si limitava al ruolo di collaboratore, canalizzando attraverso il suo bulino le invenzioni altrui. Dopo la morte del padre, aprì una sua bottega vicino S. Ignazio. Riprodusse opere di Bernini, di Pietro da Cortona, di G. Lanfranco, ecc., e illustrò vari libri. Morì a Roma nel 1662.
|