



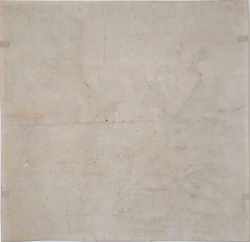
| Riferimento: | S47093 |
| Autore | Guillaume Courtois [Guglielmo Cortesi] |
| Anno: | 1656 ca. |
| Misure: | 300 x 300 mm |


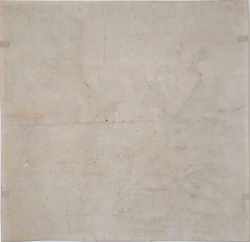
| Riferimento: | S47093 |
| Autore | Guillaume Courtois [Guglielmo Cortesi] |
| Anno: | 1656 ca. |
| Misure: | 300 x 300 mm |
Abdon e Sennen portano via per la sepoltura i primi martiri cristiani: due uomini trasportano a destra un cadavere disteso su un lenzuolo, un altro cadavere giace a terra a sinistra e a destra un ragazzo regge una torcia; dietro di loro si vedono le mura della città.
Acquaforte, circa 1656/57, con la scritta a margine "Heu ad omnes abominationes malorum domus Israel quia peste ruituri sunt. Ezechiel VI" e firmata a destra "Gul.mo Cortese pinxit et sculp".
Esemplare del primo stato di tre, o secondo di quattro, prima dell’indirizzo di Arnold van Westerouth. È noto uno stato di prova, senza la lettera.
Tratto dall'affresco di Guglielmo Cortese [Guillaume Courtois, 1628-1679] nella navata di San Marco, la chiesa veneziana a Roma. Questo ciclo di affreschi fu realizzato dagli allievi di Pietro da Cortona, sotto la sua direzione, negli anni Cinquanta del Seicento, e raffigurava scene della vita di San Marco e dei primi martiri cristiani Abdon e Sennen. L’iscrizione in basso, aggiunta in seguito probabilmente dallo stampatore, modifica l'interpretazione della scena, trasformandola nella piaga d'Israele descritta da Ezechiele.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva, irregolarmente rifilata al rame, piega di stampa orizzontale, per il resto in ottimo stato di conservazione.
Guidati dalla torcia di un giovane, i santi Abdon e Sennen, due giovani persiani recentemente convertiti al cristianesimo, si sforzano di trasportare il corpo di un altro cristiano alla sepoltura. Uno dei santi ha la testa china in segno di riflessione, mentre l'altro, che fatica a sostenere la parte più pesante del corpo del martire, guarda indietro per osservare il prossimo cadavere che dovrà essere sepolto, sebbene sia già notte fonda. Questa toccante scena documenta una delle due opere eseguite per la sua prima importante commissione dal giovane Guillaume Courtois, quando era ancora membro della bottega di Pietro da Cortona. Fu dipinta nella navata della Basilica di San Marco a Roma (1654-56), che lui e altri giovani artisti della bottega di Cortona decorarono con scene della vita di San Marco e dei suoi primi contemporanei cristiani sotto la direzione del maestro. L'affresco attirò su Courtois grande attenzione, assicurandogli future commissioni a San Marco e altrove. Questo successo, unito allo scoppio della peste a Roma nel 1656, potrebbe averlo spinto a incidere la sua composizione – con un'iscrizione tratta da una delle visioni apocalittiche del profeta Ezechiele – cosa che ha causato frequenti confusioni sul soggetto raffigurato.
La realizzazione dell'affresco e dell'incisione è il risultato della già autorevole padronanza di Courtois della forma e del disegno. Fu un disegnatore prolifico, la cui mano rivela l'influenza del suo maestro e di altri contemporanei, come Pier Francesco Mola, Giovanni Francesco Romanelli, Giovanni Lanfranco e Gian Lorenzo Bernini. Qui, in modo molto efficace, ha ampliato un motivo preso in prestito da Raffaello tramite Poussin, e se la nuova forza e il nuovo significato che sperava di conferire al gruppo figurativo non sono più visibili nell'affresco danneggiato, sono brillantemente dimostrati dalla vivace fattura del suo schizzo a olio esistente e dal tratteggio aggressivo della sua stampa. A differenza dei suoi predecessori, Courtois ha immerso queste figure in un'oscurità cupa. La scelta di un'ambientazione notturna potrebbe essere un tentativo di simulare sia l'oscurità delle azioni umane sia il rimorso generato dalle loro conseguenze.
Il monumentale gruppo di figure è spinto diagonalmente in primo piano, e la fusione dei contorni enfatici con il bianco del foglio fornisce un volume palpabile e un ritmo ampio e lento. Un tratteggio incrociato regolare, così come un tratteggio aperto e vigorosamente direzionale, giustapposto a pochi rari spazi non incisi, fa sì che le figure sembrino emergere da un'oscurità animata, e l'intera superficie del foglio vibra di energia. Courtois tentò di imitare la fattura esuberante e la satura colorazione veneziana della sua pittura, che ebbe grande successo. Questi tratti apertamente barocchi e italiani in un artista arrivato in Italia in giovane età potrebbero indurre a considerarlo interamente italiano. Tuttavia, la leggera, momentanea riduzione del movimento che percepiamo nelle figure classicheggianti, la mancanza di una prospettiva a punto unico e i gesti o i movimenti ripetuti nei piani successivi della composizione, tutto significa la base francese della sua cultura visiva transnazionale. (cfr. Sue Welsh Reed, French Prints from the Age of the Musketeers, pp. 197-199).
Il pittore Guillaume Courtois nacque in una famiglia di artisti della Franca Contea, che faceva parte dell'antico ducato di Borgogna e fu acquisita dalla Francia nel 1678. Nel 1640, lui e il fratello maggiore Jacques, anch'egli pittore, si trovavano a Roma, dove risiedettero per la maggior parte della loro vita. Entrambi gli artisti, chiamati "Cortese", sono stati chiamati "il Borgognone", come il loro connazionale François Perrier. Guillaume entrò nello studio di Pietro da Cortona e assistette questo maestro del tardo barocco negli affreschi nelle chiese romane: lavorò anche per Gianlorenzo Bernini. Proseguì poi in modo indipendente, ricevendo numerose commissioni per chiese e palazzi romani come pittore di scene storiche, mitologiche e di battaglia, oltre a soggetti religiosi. Collaborò frequentemente con il fratello e con Gaspari Dughet, cognato di Nicolas Pousin, paesaggista e acquafortista. Nel 1647 Courtois fu ammesso all'Accademia di San Luca a Roma. Gli sono attribuite sette incisioni all'acquaforte, la maggior parte delle quali riproduce dipinti di artisti italiani precedenti come Veronese e Tintoretto. Solo i Santi Abdan e Sennen, di ampia esecuzione, sono di sua progettazione, sebbene derivino da un gruppo di figure utilizzato sia da Raffaello che da Poussin.
Bibliografia
Robert-Dumesnil, Le Peintre-Graveur Français (I.213.1); Sue Welsh Reed, French Prints from the Age of the Musketeers, pp. 197-199, n. 105; 'Pietro da Cortona', Palazzo Venezia Rome, 1997, p. 224.
Guillaume Courtois [Guglielmo Cortesi] (Saint-Hippolyte, 1628 – Roma, 15 giugno 1679)
|
Guillaume Courtois o Guglielmo Cortesi è stato un pittore e incisore francese. Fratello del pittore gesuita Jacques Courtois, fu soprannominato il Borgognone. Giunse in Italia assieme al padre ed al fratello quand'era ancora bambino. Si trasferì a Roma nel 1638 e studiò presso Pietro da Cortona, esercitandosi disegnando dal vero e copiando opere di Giovanni Lanfranco e Andrea Sacchi. Studiò anche i pittori bolognesi e il Guercino e assunse uno stile classicheggiante con un leggero evidente manierismo, in parte somigliante a quello di Carlo Maratta. Dapprima veloce operatore, fu sottostimato perché non poteva terminare i suoi quadri. Poi un'opera realizzata per l'ambasciatore di Venezia gli permise di farsi conoscere per il pittore di talento che era e gli procurò lodi da Pietro da Cortona stesso. Gli furono commissionati, allora, affreschi in San Giovanni in Laterano, nella galleria del Palazzo del Quirinale (La battaglia di Giosuè), in Santa Prassede (la volta della Cappella Cesi, oggi dedicata a San Pio X, con Dio benedicente e i Santi). Eseguì parecchi studi a sanguigna che dimostrano la sua particolare attenzione nella preparazione delle figure per i suoi dipinti e composizioni disegnate a penna, inchiostro e acquerello. Lavorò anche in cooperazione con il fratello, eseguendo alcune opere per i conventi dei Gesuiti. Collaborò con Gian Lorenzo Bernini durante il pontificato di Alessandro VII, ottenendo, grazie a lui, commissioni per la decorazione di chiese in Roma e nel circondario. Guillaume Courtois morì di gotta il 15 giugno 1679.
|
Guillaume Courtois [Guglielmo Cortesi] (Saint-Hippolyte, 1628 – Roma, 15 giugno 1679)
|
Guillaume Courtois o Guglielmo Cortesi è stato un pittore e incisore francese. Fratello del pittore gesuita Jacques Courtois, fu soprannominato il Borgognone. Giunse in Italia assieme al padre ed al fratello quand'era ancora bambino. Si trasferì a Roma nel 1638 e studiò presso Pietro da Cortona, esercitandosi disegnando dal vero e copiando opere di Giovanni Lanfranco e Andrea Sacchi. Studiò anche i pittori bolognesi e il Guercino e assunse uno stile classicheggiante con un leggero evidente manierismo, in parte somigliante a quello di Carlo Maratta. Dapprima veloce operatore, fu sottostimato perché non poteva terminare i suoi quadri. Poi un'opera realizzata per l'ambasciatore di Venezia gli permise di farsi conoscere per il pittore di talento che era e gli procurò lodi da Pietro da Cortona stesso. Gli furono commissionati, allora, affreschi in San Giovanni in Laterano, nella galleria del Palazzo del Quirinale (La battaglia di Giosuè), in Santa Prassede (la volta della Cappella Cesi, oggi dedicata a San Pio X, con Dio benedicente e i Santi). Eseguì parecchi studi a sanguigna che dimostrano la sua particolare attenzione nella preparazione delle figure per i suoi dipinti e composizioni disegnate a penna, inchiostro e acquerello. Lavorò anche in cooperazione con il fratello, eseguendo alcune opere per i conventi dei Gesuiti. Collaborò con Gian Lorenzo Bernini durante il pontificato di Alessandro VII, ottenendo, grazie a lui, commissioni per la decorazione di chiese in Roma e nel circondario. Guillaume Courtois morì di gotta il 15 giugno 1679.
|