



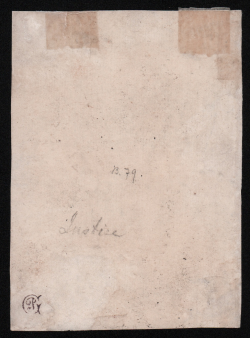
| Riferimento: | A51038 |
| Autore | Albrecht DURER |
| Anno: | 1499 ca. |
| Misure: | 75 x 105 mm |


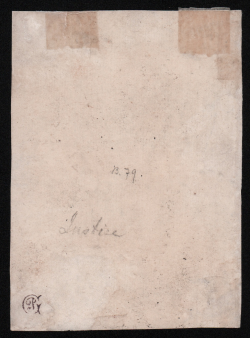
| Riferimento: | A51038 |
| Autore | Albrecht DURER |
| Anno: | 1499 ca. |
| Misure: | 75 x 105 mm |
Bulino, 1499 circa, monogrammato in lastra in basso al centro.
Esemplare con caratteristiche della prima e seconda variante (di quattro) descritta da Meder, prima dei graffi di lastra che compaiono sotto le spalle della figura allegorica della Giustizia.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva priva di filigrana, rifilata al segno del rame su tre lati, poco entro nella parte superiore, in buono stato di conservazione.
“Malgrado le sue dimensioni ridotte, è una delle più impressionanti creazioni di Dürer. Un uomo con l'aureola e con gli attributi della giustizia - la bilancia e la spada - sta seduto su un leone modellato su quelli che Dürer aveva schizzato a Venezia. Le gambe incrociate richiamano parimenti l'idea della giustizia; questo atteggiamento, che denota uno stato mentale calmo e superiore, era effettivamente prescritto ai giudici negli antichi libri germanici delle leggi. Ma il volto dell'uomo è circondato da un'aureola palpitante, e i suoi occhi sprizzano fiamme, come quelli del Figliolo dell'uomo nella Visione dei sette candelabri, i suoi tratti de-notano un'espressione feroce eppure dolorosa, stranamente affine a quella della sua fantastica cavalcatura. L'aureola e le fiamme ricordano il verso: "La sua espressione era come quando il sole brilla in tutta la sua forza"; e questa era davvero l'idea che Dürer desiderava rappresentare. L'astrologia aveva stabilito un nesso speciale tra ciascuno dei sette pianeti (che, prima di Copernico, comprendevano la luna e il sole) e ognuno uno dei dodici segni dello zodiaco. Ad ogni pianeta erano state assegnate due "stazioni" zodiacali, una per il giorno e una per la notte, tranne che alla luna che aveva bisogno di una casa solo per la notte, e al sole per il quale valeva l'inverso. La sua "stazione" era il Leone, il segno di luglio, quando è all'apice del suo potere, e questa associazione veniva raffigurata in molte diverse maniere. Una, particolare all'oriente musulmano, era di collocare la figura del Sole sul dorso del suo Leone, ed uno dei rari esemplari non musulmani di questo tipo si trova in un luogo in cui poteva facilmente aver attratto l'attenzione di Dürer: in uno dei capitelli nel palazzo ducale di Venezia, la città più orientale del mondo occidentale. Questa figura è quindi il modello visuale dell'incisione di Dürer: un Sole sul suo segno zodiacale, il Leone. Ma perché questa immagine astrologica venne rappresentata con gli attributi della giustizia? La risposta sta in un verso di Malachia: "Ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia." Sulla base di questo verso i Padri della chiesa avevano trasformato la suprema divinità dell’Impero Romano, il "Sol Invictus," in un "Sol Iustitiae" - sostituendo così alla forza naturale di una divinità astrale che dà la vita e somministra la morte il potere morale di Cristo. Questa audace equazione atta a gettare il timore del giudizio nel cuore dei fedeli, sopravvisse per più di un millennio; e in uno dei più diffusi manuali teologici del tardo medioevo, il Repertorium morale di Petrus Berchorius, troviamo un passo che deve essere considerato come la diretta fonte di ispirazione di Dürer, tanto più che questo manuale era stato stampato da Koberger nel 1489 e di nuovo nel 1498, l'anno stesso in cui fu probabilmente concepita questa incisione. Il passo suona così: "Il Sole della Giustizia apparirà infiammato [inflammatus] quando egli giudicherà l'umanità nel giorno del giudizio ed egli sarà in fuoco e torvo. Infatti, come il sole brucia le erbe e i fiori in estate quando si trova nel Leone [in leone], così Cristo apparirà come un uomo feroce e leonino [homo ferus et leoninus) nel calore del giudizio e inaridirà i peccatori...' Solo la "immaginativa stravagante" di Dürer era in grado di caricare la forma di una insignificante immagine astrologica con il contenuto di una visione apocalittica. La sua incisione servì come modello a numerosi artisti successivi, ma essi o se ne servirono per una rap-presentazione del Sole planetario, tralasciando qualunque riferimento all'idea di Giustizia, oppure per allegorie della Giustizia senza la grandiosità di una prospettiva cosmologica. Non uno fu in grado di riafferrare il concetto di un Sole che è insieme Giustizia e Cristo” (cfr. E. Panofsky La vita e le opere di Albrecht Dürer, Londra 1965 Milano 1967, pagg. 104-5).
Al verso timbro della collezione di Peter Gellatly (1831-1912) descritto da Lugt al numero 1185.
Bibliografia
Bartsch 79; Strauss 25; Meder 73, a-b/d.
Albrecht DURER (Norimberga 1471 - 1528)
|
Pittore, disegnatore, incisore e teorico dell'arte tedesco (Norimberga 1471-1528). Figlio dell'orafo magiaro Albrecht il Vecchio, fu apprendista nella bottega paterna dal 1483 al 1486; poi studiò presso Michael Wolgemut, il maggior pittore e xilografo di Norimberga. Nel 1490 Dürer iniziò un lungo viaggio nelle terre tedesche; nel 1492 soggiornò a Colmar, poi fu a Basilea e a Strasburgo (1493). Lavorando di volta in volta nei luoghi dove soggiornava, Dürer si fece un nome anche come xilografo. Nel 1494 tornò a Norimberga (dove sposò Agnes Frey), e ripartì subito dopo per Venezia. Stabilitosi in patria nel 1495, vi aprì una bottega fiorentissima e un anno dopo ebbe inizio il lungo sodalizio con il grande elettore di Sassonia Federico il Saggio. Negli anni 1505-07 fu ancora a Venezia: già celebre, soprattutto per le sue incisioni, fu al centro della raffinata società di nobili, artisti e umanisti della Serenissima. Tornato a Norimberga ebbe la protezione di Massimiliano I, lavorando specialmente come xilografo, fino al 1519, anno della morte dell'imperatore. A Norimberga continuò la sua attività, sebbene a ritmo meno serrato per il fisico indebolito da una grave malattia, occupandosi inoltre fino alla morte della pubblicazione delle sue opere teoriche. Nelle primissime opere sono già realizzati pienamente quei caratteri di acuta penetrazione psicologica e di trasfigurato realismo che saranno costanti nella sua opera. Il primo viaggio a Venezia (1494-95), con puntate anche a Padova e a Mantova, fu fondamentale per il completamento della sua formazione, che si arricchì del plastico monumentalismo di Mantegna e delle armonie classiche del Pollaiolo e di Giovanni Bellini. Nel 1498 Dürer illustrò l'Apocalisse con 15 xilografie che rappresentano uno dei massimi capolavori dell'arte tedesca. Tra queste tavole: S. Giovanni davanti a Dio e ai vegliardi, i Quattro Cavalieri, il S. Michele. La popolarità e la larga diffusione che ebbe l'Apocalisse toccò anche alle xilografie eseguite per altri cicli religiosi: la Grande Passione (iniziata 1500, edita 1511, di cui si ricorda l'Ecce Homo), la Piccola Passione (1509-11), la Vita della Vergine (1500-11, comprendente la famosa tavola con il Riposo durante la fuga in Egitto), nei quali è evidente il proposito di una nuova interpretazione del Vangelo. In questi stessi anni Dürer eseguì numerose pale d'altare (spesso con aiuti di bottega), creando capolavori in cui lo spazio prospettico, i colori di smalto, il senso della quotidianità del divino sono le caratteristiche essenziali.Il secondo viaggio a Venezia gli pose problemi più specificamente coloristici, stimolati dal contatto con Giorgione e Tiziano. Rivolse inoltre la sua attenzione al nudo classico vitruviano (incisione con Adamo ed Eva, 1504), ma si sciolse dalle rigidezze canoniche, per un ideale di bellezza tutta umana, con le tavole a olio a grandezza naturale dell'Adamo ed Eva del Prado (1507). Ben presto tornò però a esprimersi con l'incisione, realizzando le sue 3 opere più note: Cavaliere, la Morte e il Diavolo (1513), S. Girolamo nello studio (1514), Melencolia I (1514). Nell'ultimo periodo di vita si occupò principalmente della pubblicazione dei suoi scritti teorici, arricchiti da disegni scientifici: il trattato di geometria (1525); il trattato sulle fortificazioni (1527); il trattato sulle proporzioni (1528). Con essi, oltre alla divulgazione dei principi matematici che erano alla base dell'arte rinascimentale italiana, Dürer si proponeva di trasmettere le conclusioni cui era giunto in merito alla creazione artistica: in un vero artista, al Brauch, l'abilità tecnica, doveva accompagnarsi la Kunst, la capacità intellettuale di teorizzare e realizzare i principi generali dell'arte, concetto strettamente connesso alla figura dell'artista umanista e gentiluomo.
|
Albrecht DURER (Norimberga 1471 - 1528)
|
Pittore, disegnatore, incisore e teorico dell'arte tedesco (Norimberga 1471-1528). Figlio dell'orafo magiaro Albrecht il Vecchio, fu apprendista nella bottega paterna dal 1483 al 1486; poi studiò presso Michael Wolgemut, il maggior pittore e xilografo di Norimberga. Nel 1490 Dürer iniziò un lungo viaggio nelle terre tedesche; nel 1492 soggiornò a Colmar, poi fu a Basilea e a Strasburgo (1493). Lavorando di volta in volta nei luoghi dove soggiornava, Dürer si fece un nome anche come xilografo. Nel 1494 tornò a Norimberga (dove sposò Agnes Frey), e ripartì subito dopo per Venezia. Stabilitosi in patria nel 1495, vi aprì una bottega fiorentissima e un anno dopo ebbe inizio il lungo sodalizio con il grande elettore di Sassonia Federico il Saggio. Negli anni 1505-07 fu ancora a Venezia: già celebre, soprattutto per le sue incisioni, fu al centro della raffinata società di nobili, artisti e umanisti della Serenissima. Tornato a Norimberga ebbe la protezione di Massimiliano I, lavorando specialmente come xilografo, fino al 1519, anno della morte dell'imperatore. A Norimberga continuò la sua attività, sebbene a ritmo meno serrato per il fisico indebolito da una grave malattia, occupandosi inoltre fino alla morte della pubblicazione delle sue opere teoriche. Nelle primissime opere sono già realizzati pienamente quei caratteri di acuta penetrazione psicologica e di trasfigurato realismo che saranno costanti nella sua opera. Il primo viaggio a Venezia (1494-95), con puntate anche a Padova e a Mantova, fu fondamentale per il completamento della sua formazione, che si arricchì del plastico monumentalismo di Mantegna e delle armonie classiche del Pollaiolo e di Giovanni Bellini. Nel 1498 Dürer illustrò l'Apocalisse con 15 xilografie che rappresentano uno dei massimi capolavori dell'arte tedesca. Tra queste tavole: S. Giovanni davanti a Dio e ai vegliardi, i Quattro Cavalieri, il S. Michele. La popolarità e la larga diffusione che ebbe l'Apocalisse toccò anche alle xilografie eseguite per altri cicli religiosi: la Grande Passione (iniziata 1500, edita 1511, di cui si ricorda l'Ecce Homo), la Piccola Passione (1509-11), la Vita della Vergine (1500-11, comprendente la famosa tavola con il Riposo durante la fuga in Egitto), nei quali è evidente il proposito di una nuova interpretazione del Vangelo. In questi stessi anni Dürer eseguì numerose pale d'altare (spesso con aiuti di bottega), creando capolavori in cui lo spazio prospettico, i colori di smalto, il senso della quotidianità del divino sono le caratteristiche essenziali.Il secondo viaggio a Venezia gli pose problemi più specificamente coloristici, stimolati dal contatto con Giorgione e Tiziano. Rivolse inoltre la sua attenzione al nudo classico vitruviano (incisione con Adamo ed Eva, 1504), ma si sciolse dalle rigidezze canoniche, per un ideale di bellezza tutta umana, con le tavole a olio a grandezza naturale dell'Adamo ed Eva del Prado (1507). Ben presto tornò però a esprimersi con l'incisione, realizzando le sue 3 opere più note: Cavaliere, la Morte e il Diavolo (1513), S. Girolamo nello studio (1514), Melencolia I (1514). Nell'ultimo periodo di vita si occupò principalmente della pubblicazione dei suoi scritti teorici, arricchiti da disegni scientifici: il trattato di geometria (1525); il trattato sulle fortificazioni (1527); il trattato sulle proporzioni (1528). Con essi, oltre alla divulgazione dei principi matematici che erano alla base dell'arte rinascimentale italiana, Dürer si proponeva di trasmettere le conclusioni cui era giunto in merito alla creazione artistica: in un vero artista, al Brauch, l'abilità tecnica, doveva accompagnarsi la Kunst, la capacità intellettuale di teorizzare e realizzare i principi generali dell'arte, concetto strettamente connesso alla figura dell'artista umanista e gentiluomo.
|