



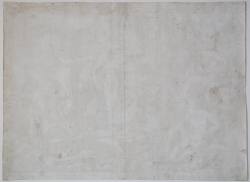
| Riferimento: | S50313 |
| Autore | Pietro TESTA detto "Il Lucchesino" |
| Anno: | 1644 ca. |
| Misure: | 575 x 420 mm |


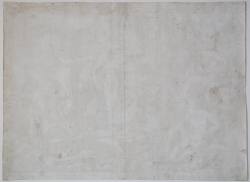
| Riferimento: | S50313 |
| Autore | Pietro TESTA detto "Il Lucchesino" |
| Anno: | 1644 ca. |
| Misure: | 575 x 420 mm |
Acquaforte, circa 1644/46, firmata dall’editore Giovanni Domenico De rossi in basso nella dedica a Tommaso Rondenino: All'Ill.mo Sig. Tomaso Rondenino Cavalier Gerosoli-mitano./Chi cammina per la via della Virtu con la scorta del lume della sapienza non puo far a meno che la fama non li ap presti corone e trionfi V. S. Ill.ma che calca anch'essa il medesimo sentiero miri in questo delineamento del Sig.r Testa espresso un ritratto delle sue virtuose operazioni e gli eventi del suo merito quale incatenera'/ il tempo e loserbera immortale, ad onta della morte dall'espressione di questa verita' riconosca a V.S. Ill.ma il mio ossequio ef humiliss:te me li inchino Di V.S. Ill.ma Devotissimo et obligatissimo Servitore Gio. Domenico Rossi.
Esemplare nel secondo stato di tre, con la dedica a Rondenino.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva con filigrana “cerchio e giglio”, rifilata la rame, tracce di colla e piccoli strappetti restaurati visibili al verso, per il resto in buono stato di conservazione.
Il significato allegorico di questa scena è legato a un profondo senso morale: il giovane virtuoso, l'Eroe puro, raffigurato nudo al centro, è arrivato attraverso un sentiero stretto ed impervio al Parnaso, è coronato dalla Fama e illuminato dalla fiaccola della Saggezza, mentre alle sue spalle fuggono vinte l'Ignoranza, l'Invidia e gli altri Vizi, accompagnate da un asino e da una scimmia.
Sul Parnaso, santuario idilliaco per il poeta e l'artista, sono pronti ad accoglierlo sedute, le Muse circondate da putti, tra le quali emerge Erato con la testa coronata; in primo piano è il Tempo, raffigurato secondo l'iconografia classica di Saturno, vecchio, alato, con la Clessidra. È evidente che con questa messa in scena allegorica dell'arrivo dell'artista saggio sul monte Parnaso, il Testa ha voluto celebrare la sua profonda convinzione filosofica del Trionfo del vizio sull'ignoranza, e in senso traslato il suo proprio trionfo quale artista puro nei confronti dei suoi denigratori e rivali, veri o immaginari (sappiamo che il Testa soffriva di manie di persecuzione, che lo portarono proprio in quegli anni al suicidio).
Databile al momento di maggior intellettualismo dell'autore, tra gli anni 1645 e 1650, alcuni critici, tra cui il Bellini, hanno avanzato riserve sulla totale autografia di questa incisione a Testa, avanzando l'ipotesi che la parte inferiore destra sia stata portata a termine da Giulio Cesare Testa.
Se pure vi furono degli interventi esterni, l'idea compositiva generale è dovuta senz'altro alla mente colta dell'incisore lucchese.
Secondo il biografo Passeri, nel volto del giovane virtuoso è da ravvisare il ritratto idealizzato dello stesso Testa. Infatti, si conoscono numerosi disegni preparatori di grande qualità, per questa incisione, tra i quali il più celebre è lo studio definitivo della composizione conservato nel Teylers Museum di Haarlem (Cropper, 1988, n. 103) quadrettato per la trasposizione, nonché studi vari di figure.
La vicenda artistica di Pietro Testa, detto il Lucchesino dalla sua città d’origine, è assai tormentata. Poco o nulla si sa del suo primo apprendistato nella città natale. Arrivato a Roma nel 1629, fu probabilmente dapprima a scuola presso il Domenichino, poi presso la bottega di Pietro da Cortona, suo vero maestro. Il carattere introverso dell’artista gli procurò comunque sempre difficoltà con i suoi colleghi: il Cortona, infatti, fu costretto a cacciarlo dalla sua scuola per l’atteggiamento di sprezzante superiorità assunta dall’allievo. Il Testa frequentò allora la casa del suo primo mecenate, il celebre collezionista Cassiano del Pozzo, per il quale eseguì disegni dall’antico. Fu probabilmente nella sua casa che conobbe il pittore Nicolas Poussin, che influenzerà profondamente la sua arte sia nella sua prima fase di adesione tizianesca al movimento neo-veneto, sia nel periodo più maturo, a partire dagli anni 1635 in poi, caratterizzati da un intellettualismo classicheggiante. Resta comunque il fatto che le sue incisioni (che ammontano a 40 tavole circa) furono considerate fin dall’antichità, a partire dal Sandrart e dal Baldinucci, le opere grafiche più importanti del '600 italiano.
Bibliografia
Cropper, Pietro Testa, pp. 224-227, n. 102; Bartsch 33, Bellini 33, II/III; Massari, Tra Mito ed Allegoria, pp. 540-541, n. 222, II/III.
Pietro TESTA detto "Il Lucchesino" (Lucca 1611 - Roma 1650)
|
La vicenda artistica di Pietro Testa, detto il Lucchesino dalla sua città d’origine, è assai tormentata. Poco o nulla si sa del suo primo apprendistato nella città natale. Arrivato a Roma nel 1629, fu probabilmente dapprima a scuola presso il Domenichino, poi presso la bottega di Pietro da Cortona, suo vero maestro. Il carattere introverso dell’artista gli procurò comunque sempre difficoltà con i suoi colleghi: il Cortona infatti fu costretto a cacciarlo dalla sua scuola per l’atteggiamento di sprezzante superiorità assunta dall’allievo .
Il Testa frequentò allora la casa del suo primo mecenate, il celebre collezionista Cassiano del Pozzo, per il quale eseguì disegni dall’antico. Fu probabilmente nella sua casa che conobbe il pittore Nicolas Poussin, che influenzerà profondamente la sua arte sia nella sua prima fase di adesione tizianesca al movimento neo-veneto, sia nel periodo più maturo, a partire dagli anni 1635 in poi, caratterizzati da un intellettualismo classicheggiante.
Resta comunque il fatto che le sue incisioni (che ammontano a 40 tavole circa) furono considerate fin dall’antichità, a partire dal Sandrart e dal Baldinucci, le opere grafiche più importanti del '600 italiano.
Nelle ultime incisioni l’artista illustra attraverso complesse simbologie a sfondo classicheggiante o mitologico la morale stoica che aveva adottato. Questa concezione pessimistica dell’esistenza e di un dramma cosmico che avvolge l’umanità giustifica la malinconia e la solitudine degli ultimi anni dell’artista, di cui parlano i biografi, e prelude al dramma finale del suicidio del Testa buttatosi nel Tevere nei pressi della Lungara nel 1650.
|
Pietro TESTA detto "Il Lucchesino" (Lucca 1611 - Roma 1650)
|
La vicenda artistica di Pietro Testa, detto il Lucchesino dalla sua città d’origine, è assai tormentata. Poco o nulla si sa del suo primo apprendistato nella città natale. Arrivato a Roma nel 1629, fu probabilmente dapprima a scuola presso il Domenichino, poi presso la bottega di Pietro da Cortona, suo vero maestro. Il carattere introverso dell’artista gli procurò comunque sempre difficoltà con i suoi colleghi: il Cortona infatti fu costretto a cacciarlo dalla sua scuola per l’atteggiamento di sprezzante superiorità assunta dall’allievo .
Il Testa frequentò allora la casa del suo primo mecenate, il celebre collezionista Cassiano del Pozzo, per il quale eseguì disegni dall’antico. Fu probabilmente nella sua casa che conobbe il pittore Nicolas Poussin, che influenzerà profondamente la sua arte sia nella sua prima fase di adesione tizianesca al movimento neo-veneto, sia nel periodo più maturo, a partire dagli anni 1635 in poi, caratterizzati da un intellettualismo classicheggiante.
Resta comunque il fatto che le sue incisioni (che ammontano a 40 tavole circa) furono considerate fin dall’antichità, a partire dal Sandrart e dal Baldinucci, le opere grafiche più importanti del '600 italiano.
Nelle ultime incisioni l’artista illustra attraverso complesse simbologie a sfondo classicheggiante o mitologico la morale stoica che aveva adottato. Questa concezione pessimistica dell’esistenza e di un dramma cosmico che avvolge l’umanità giustifica la malinconia e la solitudine degli ultimi anni dell’artista, di cui parlano i biografi, e prelude al dramma finale del suicidio del Testa buttatosi nel Tevere nei pressi della Lungara nel 1650.
|