



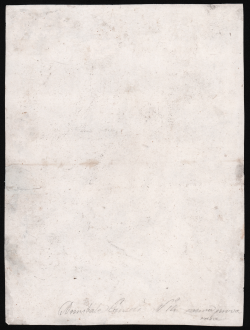
| Riferimento: | S47064 |
| Autore | Annibale CARRACCI |
| Anno: | 1591 |
| Misure: | 190 x 255 mm |


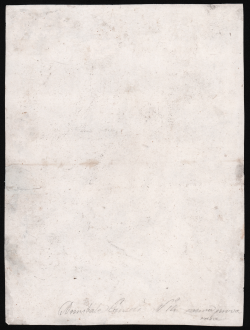
| Riferimento: | S47064 |
| Autore | Annibale CARRACCI |
| Anno: | 1591 |
| Misure: | 190 x 255 mm |
San Girolamo nel deserto; il santo è inginocchiato al centro e guarda verso il cielo, regge la veste con la mano destra e una pietra nella sinistra, con libri, un teschio e un crocifisso accanto.
Acquaforte e bulino, circa 1591. Esemplare del primo stato, ante l’indirizzo di Pietro Stefanoni.
Buona impressione, stampata su carta vergata coeva, rifilata alla linea marginale, tracce di colla e minimo restauro visibili sul verso, per il resto in buone condizioni.
“San Girolamo è qui raffigurato non semplicemente come un penitente che medita nel deserto, ma come una figura sacra in un momento di estasi spirituale, in comunione con il suo Dio, come si vede in opere come la Conversione di Saul di Caravaggio, la Visione di Santa Teresa di Bernini e il San Girolamo di Ribera, per citare solo gli esempi più convincenti. Come Caravaggio, Bernini e Ribera, Annibale si è impegnato a convincere l'osservatore della realtà del miracolo: che Dio può apparire agli uomini mortali sulla terra e che la possessione divina è plausibile come un fenomeno puramente personale che si verifica all'interno di un individuo in un contesto concreto. A tal fine, San Girolamo è solido, robusto e reso realisticamente; come un grande masso, sembra essere parte della natura selvaggia che lo circonda.
La tecnica di Annibale qui – per lo più acquaforte con qualche ritocco a bulino – si adatta mirabilmente alle esigenze espressive della stampa. I suoi tratti incisi, pesanti, decisi e deliberati e i tratteggi densi e corposi si adattano la sobria imponenza della composizione. Il peso relativamente indifferenziato delle linee incise sia nella figura che nell'ambiente contribuisce a intrecciare San Girolamo nella natura selvaggia di alberi, rocce e fogliame. Il volto e la barba, al contrario, sono definiti da linee più chiare e abbozzate, a suggerire che la loro sostanza materiale sia stata dissolta dalla luce divina che pulsa nell'aureola del santo” cf. Richard Wallace in Italian Etchers of the Reinassance & Barocque, pp. 108-109).
Bibliografia
Bartsch, Le Peintre graveur (XVIII.190.14); Bohlin 1979, Prints and related drawings by the Carracci family (13.I); Posner 1971; Annibale Carracci, a study in the reform of Italian painting around 1590 (64); Welsh & Reed, Italian Etchers of the Reinassance & Barocque, pp. 108-109, n. 51.
Annibale CARRACCI (Bologna 1560 - Roma 1609)
|
Fratello minore di Agostino e cugino di Ludovico, di cui fu allievo, è il maggior esponente della scuola bolognese del Seicento, e tra i più grandi esponenti del classicismo italiano del XVII secolo. Dopo un inizio ancora aderente alla cultura tardomanieristica locale, legata ad un realismo alla Campi, l’artista matura il suo linguaggio espressivo cogliendolo dai grandi del Rinascimento italiano, per raggiungere a Roma, con il suo capolavoro degli affreschi in Palazzo Farnese (1595-1604 circa), la più alta espressione della cultura classicista italiana. Seguendo l’esempio di Agostino, l’artista si dilettò anche in incisioni, unendo la tecnica del bulino a quella dell’acquaforte: il suo catalogo di grafica conta 17 stampe, la maggior parte delle quali di soggetto religioso, e solo due di tema mitologico dove rivive a pieno lo spirito alessandrino della favola mitologica.
|
Annibale CARRACCI (Bologna 1560 - Roma 1609)
|
Fratello minore di Agostino e cugino di Ludovico, di cui fu allievo, è il maggior esponente della scuola bolognese del Seicento, e tra i più grandi esponenti del classicismo italiano del XVII secolo. Dopo un inizio ancora aderente alla cultura tardomanieristica locale, legata ad un realismo alla Campi, l’artista matura il suo linguaggio espressivo cogliendolo dai grandi del Rinascimento italiano, per raggiungere a Roma, con il suo capolavoro degli affreschi in Palazzo Farnese (1595-1604 circa), la più alta espressione della cultura classicista italiana. Seguendo l’esempio di Agostino, l’artista si dilettò anche in incisioni, unendo la tecnica del bulino a quella dell’acquaforte: il suo catalogo di grafica conta 17 stampe, la maggior parte delle quali di soggetto religioso, e solo due di tema mitologico dove rivive a pieno lo spirito alessandrino della favola mitologica.
|