




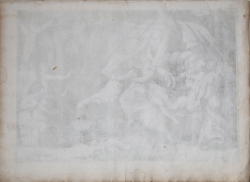
| Riferimento: | S48413 |
| Autore | Giulio BONASONE |
| Anno: | 1540 ca. |
| Misure: | 435 x 300 mm |



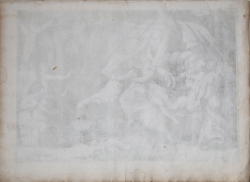
| Riferimento: | S48413 |
| Autore | Giulio BONASONE |
| Anno: | 1540 ca. |
| Misure: | 435 x 300 mm |
Bulino, 1540-46 circa, firmato in lastra in basso a destra. Da un soggetto di Polidoro da Caravaggio.
Esemplare nel secondo stato finale, con l’indirizzo dell’editore Antonio Lafrery.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva con filigrana “pellegrino nel cerchio” (Woodward nn. 3-6), con inusulai ampi margini, minima traccia di piega centrale verticale, per il resto in perfetto stato di conservazione.
La scena rappresenta la fuga leggendaria di Clelia, eroina romana d’età repubblicana, dal campo del re etrusco Porsenna che la teneva prigioniera insieme alle sue compagne.
In seguito alla cacciata da Roma, Tarquinio il Superbo aveva chiesto aiuto alla vicina Etruria, ma solo la città di Chiusi, governata da Porsenna, accettò la richiesta. Dopo due anni d’assedio, dal 509 al 507 a.C., i due popoli stipularono la pace, e nel contesto delle trattative, i Romani consegnarono a Porsenna nove ragazze, tra le quali Clelia. L’eroina però, riuscì a fuggire attraversando il Tevere – da sola, o con le compagne, a seconda delle fonti - e quando i Romani la riconsegnarono agli Etruschi, Porsenna, colpito da tanto coraggio, decretò di liberarla. I Romani riconoscenti l'onorarono d'una statua equestre lungo la Via Sacra.
La leggenda è un tentativo di spiegare un'antica statua equestre, della quale non si sapeva più il significato, e che raffigurava, secondo l'interpretazione più comune, Venus Equestris, identificata da molti con la Venus Cluilia o Cloacina (di qui il nome Cloelia), dea della Cloaca Massima.
L’incisione, probabilmente realizzata tra il 1540 e il 1546, è tratta dall’affresco - un tempo sulla facciata di Santa Lucia della Chiavica (oggi detta del Gonfalone), a Roma - eseguito da Polidoro tra il 1525-1526, come ricorda Vasari.
Polidoro realizzò anche un altro affresco dello stesso soggetto, per la volta del Salone di Villa Lante, oggi a Palazzo Zuccari sede della Bibliotheca Hertziana, in Roma. Da quest’affresco derivò un’altra incisione che erroneamente De Wit attribuì a Bonasone, su invenzione del Rosso Fiorentino, mentre invece è opera di Pierre Milan e René Boyvin.
Bellissimo esemplare di questa rara incisione del Bonasone.
Bibliografia
Bartsch, XV.134.83; Le Blanc, I.447.343; Massari, Iulio Bonasone, p. 67 n. 73; Witcombe, p. 112.
Giulio BONASONE (Bologna circa 1500 - Roma circa 1580)
|
Giulio Bonasone, nato a Bologna nel 1510 circa, è incisore a bulino e all’acquaforte oltre che pittore come ricorda il Malaspina includendolo tra gli allievi di Lorenzo Sabbatici. Sono 410 le stampe - quasi tutte conservate all’Istituto per la Grafica di Roma - che la critica recente assegna al Bonasone ampliando il numero indicato dal Bartsch di 354 fogli. Incisore di riproduzione oltre che di invenzione, Giulio inizia la sua attività calcografica intorno al 1531, come risulta dalla data che si legge nella raffaellesca S. Cecilia. Ritenuto un seguace tardivo di Marcantonio Raimondi, il bolognese rivela presto una sostanziale autonomia di visione che lo rende uno degli interpreti più interessanti dell’epoca, tanto che lo stesso Parmigianino gli consegna i disegni per la trasposizione su rame. A Roma dal 1544 fino al 1547 ca., il Bonasone lavora per i più importanti editori – calcografi dell’epoca (Salamanca, Barlacchi, Lafrery) interpretando i soggetti di Michelangelo o di Raffaello e dei suoi principali allievi: Giulio Romano, Perin del Vaga e Polidoro da Caravaggio, in uno stile estremamente personale che si avvale di tratti a bulino spesso combinati all’acquaforte.
|
Giulio BONASONE (Bologna circa 1500 - Roma circa 1580)
|
Giulio Bonasone, nato a Bologna nel 1510 circa, è incisore a bulino e all’acquaforte oltre che pittore come ricorda il Malaspina includendolo tra gli allievi di Lorenzo Sabbatici. Sono 410 le stampe - quasi tutte conservate all’Istituto per la Grafica di Roma - che la critica recente assegna al Bonasone ampliando il numero indicato dal Bartsch di 354 fogli. Incisore di riproduzione oltre che di invenzione, Giulio inizia la sua attività calcografica intorno al 1531, come risulta dalla data che si legge nella raffaellesca S. Cecilia. Ritenuto un seguace tardivo di Marcantonio Raimondi, il bolognese rivela presto una sostanziale autonomia di visione che lo rende uno degli interpreti più interessanti dell’epoca, tanto che lo stesso Parmigianino gli consegna i disegni per la trasposizione su rame. A Roma dal 1544 fino al 1547 ca., il Bonasone lavora per i più importanti editori – calcografi dell’epoca (Salamanca, Barlacchi, Lafrery) interpretando i soggetti di Michelangelo o di Raffaello e dei suoi principali allievi: Giulio Romano, Perin del Vaga e Polidoro da Caravaggio, in uno stile estremamente personale che si avvale di tratti a bulino spesso combinati all’acquaforte.
|